[Longform] La monografia esplosiva ed esclusiva di Michel Bettane sulla Borgogna (tradotta in italiano)
di Simone Di VitoQuando un giornalista e critico di fama mondiale come Michel Bettane scrive di Borgogna è impossibile non dare un’occhiata.
Quello che segue non è però un semplice articolo (qui l’originale: “La Bourgogne, l’impasse et l’issue“) bensì una splendida monografia sulla Borgogna del vino estratta dalla rivista en Magnum (acquistabile sul sito mybettanedesseauve.fr). Cinque lunghi capitoli, densi di aneddoti e spunti fondamentali per qualsiasi professionista/appassionato, che sarebbe stato un esercizio crudele dover sintetizzare.
Ho deciso quindi di tradurre integralmente il contributo per renderlo fruibile in italiano (col prezioso contributo tecnico di Marco Colabraro) e ringrazio Michel Bettane, Thierry Desseauve e Louis Victor Chavet per aver approvato e autorizzato la versione italiana di un testo semplicemente magistrale.

[Michel Bettane. Credits foto: DNA]
La Borgogna, l’impasse e la via d’uscita | di Michel Bettane
L’occhio acuto, forgiato da quarant’anni di vendemmie consecutive, è testimone imprescindibile di una storia disorientante. E risponde a due belle questioni: Come siamo arrivati fin qui? E come uscire dalla trappola? Una monografia esplosiva ed esclusiva.
Gli amanti del vino di Borgogna lo sanno troppo bene: mai, negli ultimi tre secoli, la Borgogna vitivinicola è stata tanto venerata, così prospera e così ansiosa di un successo che le provoca più paura che gioia. Il prezzo dei vini dai migliori terroir schizza alle stelle, spesso venti o trenta volte superiore rispetto a quello dei terroir vicini − ma sconosciuti ai ricchi commercianti e speculatori. I capricci del clima, uniti a una maggiore rigidità nella coltivazione della vite, hanno portato a una diminuzione delle rese, tornate ai livelli dei secoli scorsi, il che non migliora la situazione. Le assegnazioni commerciali scarseggiano sempre di più, mentre il valore fondiario delle vigne raggiunge livelli stratosferici, ostacolando le successioni dei patrimoni familiari. Ora servono cento vendemmie o più per ripagare l’acquisto di un’ottima vigna, se ci pensiamo è un fatto mostruoso per un prodotto agricolo, che destina questa agricoltura di lusso a fungere da patrimonio supplementare per le più grandi fortune. E naturalmente, questo riempie le casse dello stato francese ad ogni successione a causa di una fiscalità confiscatoria unica in tutta l’Europa vinicola. Come siamo arrivati a questo punto? Come gli sforzi di due generazioni di produttori hanno portato a un’impasse che tutti noi speriamo sia reversibile? Cercherò di tracciarne la grande e la piccola storia, avendo avuto la fortuna di esserne testimone diretto da oltre quarant’anni.

Dissolvenza
Cinquant’ anni fa, la Borgogna tentava di liberarsi dalle sue difficoltà croniche trasformando le sue pratiche vitivinicole. Il risultato fu drammatico: perse la sua anima banalizzando i suoi vini.
Quello degli anni ’70 fu un decennio molto difficile, con almeno un raccolto interamente devastato dalla muffa grigia (1975) e numerose annate diluite dalla pioggia o derivanti da vendemmie senza buona maturità. Quando iniziai a fare i miei primi giri tra le vigne borgognone, vedevo ovunque terreni diserbati chimicamente e, per combattere i capricci del tempo (sì esatto, ma diversi da quelli odierni), ampiamente nutriti da fertilizzanti potassici che non garantivano però un buono stato sanitario dell’uva. Le bacche gonfiate dalle prime piogge scoppiavano e la muffa poteva svilupparsi in pochi giorni. Jacques d’Angerville mi aveva fornito alcune spiegazioni su queste cattive pratiche ammettendo che anche lui, tra i migliori viticoltori della sua generazione, abusava di questi stessi fertilizzanti. Le analisi del suolo mostravano un tasso di potassio ben più elevato di quanto fosse necessario ma gli stessi laboratori consigliavano di continuare ad aggiungerne. È pur vero che un influente viticoltore dell’epoca, Lucien Audidier, proprietario di splendidi cru a Nuits-Saint-Georges, aveva fatto una lunga carriera alla guida di miniere di potassio in Alsazia, ma nel frattempo in Borgogna si stava sviluppando una forma di patriottismo pro-potassio e pro-alsaziano che faceva perdere alla viticoltura ogni prospettiva critica, tanto più che le si chiedeva di produrre di più ad ogni nuovo millesimo. Gli squilibri nati da questi abusi, con troppe sostanze zuccherine nelle bacche e acidità insufficienti, sembravano facilmente correggibili con la chaptalisation (zuccheraggio), la “saignée” delle vasche e l’acidificazione, praticamente ovunque consigliate e praticate.
Anche un vinificatore meticoloso come Charles Rousseau a Gevrey aveva adottato queste pratiche quando i suoi vini del 1977 e, in parte, del 1978 e 1979, erano divenuti aceto e torbidi. Ci vorranno quasi vent’anni affinché una consapevolezza dei difetti analitici delle uve provenienti da viti sovralimentate da fertilizzanti porti a una maggiore disciplina. Purtroppo gli eccessi di potassio impiegano molto tempo a scomparire e, viceversa, terreni insufficientemente riequilibrati in materia organica indeboliscono la vigoria delle viti e, spesso, il potenziale aromatico dell’uva. Non si percepivano ancora i danni derivati dall’abuso di glifosato e prodotti sistemici, soprattutto perché, uno di essi, consentì di proteggere le viti dalla botrite nel 1980, con risultati spettacolari che oltretutto salvarono l’eccezionale vendemmia 1980 di Charles Rousseau. Da giovane giornalista e ancora molto inesperto, ero più ossessionato dalla chaptalisation che da questioni di agronomia, ma ho avuto l’enorme fortuna di incontrare alcune personalità che mi hanno permesso di comprendere meglio le sfide di un’evoluzione obbligatoria delle abitudini locali. Jacky e Bernadette Confuron, una coppia esemplare e instancabile di Vosne-Romanée, mostrarono cosa potesse dare un buon lavoro del suolo e i gesti indispensabili nella conduzione della vite, come una potatura che mantenesse la pianta nel suo spazio individuale e una pratica di diradamento che l’80% dei loro vicini aveva abbandonato. Questo consiste nel togliere i doppi germogli e migliorare l’aerazione dei grappoli per garantire un migliore stato sanitario e una maturazione più completa dell’uva. Xavier Guillaume, vivaista di Charcenne, mi illuminò sull’importanza cruciale della scelta del materiale vegetale.
Il grande dibattito di allora nelle due Côte, in particolare nella Côte de Nuits, riguardava la disputa tra due diversi cloni di pinot nero: il pinot droit e il pinot fin, detto “torto”. Il droit, sviluppandosi in forma eretta, risparmiava in modo significativo i gesti dei viticoltori, sia nel palizzamento che nella vendemmia, ed era stato selezionato da Louis Gouroux, vivaista locale e astuto viticoltore di Flagey-Échezeaux. Da viticoltore preciso, lui stesso ne limitava la vigoria mediante un diradamento sistematico e produceva vini di grande finezza, ma altri, più pigri, lasciavano sovrapprodurre le vigne e, di conseguenza, affievolivano l’espressione dei loro vini. I due schieramenti alimentavano pettegolezzi e denunce reciproche. Da una parte si fustigava l’uso del pinot droit, dall’altra i suoi sostenitori denunciavano le cattive selezioni dei loro colleghi con viti che pompavano ancor più volume in vendemmia. Tutto ciò nascondeva in realtà un deriva ben più grave, Guillaume mi aveva messo in guardia riguardo a questo con grande onestà morale e intellettuale: un terribile virus, chiamato court-noué (arricciamento), trasmesso alla vite dalle profondità del suolo attraverso micro-insetti chiamati nematodi, che minacciava di annientare la produttività delle vigne. Era quindi necessario rigenerare le viti infette. Poiché non era possibile distruggere i vettori del virus, sarebbe stato inutile continuare a ripiantare materiale anch’esso infetto nei vivai locali o nelle selezioni degli ultimi viticoltori capaci di farli.
La scienza agronomica borgognona dell’epoca, sotto l’autorità del celebre professor Raymond Bernard, ricorse a una rivoluzione nella selezione per clonazione, con la possibilità di liberare il materiale vegetale dal virus tramite processi fisici e riprodurlo sano in modo identico. Consapevole della semplificazione che questo processo rivoluzionario avrebbe potuto apportare alla popolazione dei vitigni nati da innesto post-fillossera, in particolare per il più colpito tra essi, lo chardonnay, Raymond Bernard aveva fatto selezionare e piantare sulle alture del monte Battois, sopra Beaune, una grande varietà di ceppi per studiarne il comportamento. Ma nell’urgenza, solo alcuni furono giudicati degni di essere clonati e ripiantati. Il pericolo maggiore era di una semplificazione eccessiva e soprattutto di una reazione a catena delle malattie possibili che avrebbero potuto colpire l’intero impianto. Questa selezione era stata praticata basandosi su criteri di microvinificazione e degustazione molto poco chiari e completamente soggettivi. Guillaume aveva intuito il pericolo di un’eccessiva semplificazione e soprattutto quello di una reazione a catena di possibili malattie che, sui cloni, avrebbe colpito tutte le piantagioni. Alla vista dei primi grappoli piantati, in particolare del famoso clone di pinot nero 115, i Seysses, i Montille, e persino Aubert de Villaine, si mostrarono scettici. Su alcuni chardonnay, alcuni viticoltori competenti come Jean-François Coche Dury e René Lafon addirittura si ribellarono a questa semplificazione.
Guillaume, pur vendendo i cloni mi incoraggiava a combattere questa moda sostenendo un argomento forte: una popolazione avrà certo dei difetti e degli individui malati, ma solamente una micro-diversità di carattere e di maturità può esprimere tutta la nobiltà e la complessità di un buon terroir; mentre un universo di cloni identici potrebbe degenerare all’unisono nonché affievolire il sapore finale del vino. Sono abbastanza orgoglioso di aver scritto già nel 1983 un articolo denunciando i pericoli della clonazione, naturalmente combattuto con vigore da esperti ben più di me. Ma sono ancora più orgoglioso di aver convinto Olivier Leflaive e alcuni altri viticoltori di qualità a organizzare un dibattito pubblico sulla questione. Si tenne a Bouilland a metà degli anni ’80 e per l’occasione avevo invitato Jean Delmas, direttore di Chateau Haut-Brion e il mio amico Denis Dubourdieu, agronomo emerito (formatosi a Montpellier) ed enologo rigoroso. Delmas aveva condotto uno studio affascinante sul materiale vegetale di Haut-Brion, mostrando i vantaggi di una popolazione massale selezionata con precisione. Analizzando tutti i cloni della proprietà aveva individuato dei merlot strani, capaci di sprigionare forti aromi affumicati, i quali erano stati esclusi dalla piantagione a causa dell’esoticità stessa del sapore che producevano. Eppure, in quantità molto piccole, erano proprio quelli a conferire a questo prestigioso vino tutto il suo fascino. Pensavo che potesse portare il frutto della sua esperienza ai suoi colleghi borgognoni. Dal canto suo, Denis Dubourdieu, aveva osservato, sbalordito, i protocolli delle microvinificazioni, così delicate da riuscire con successo, che si concentravano solo sul livello di zucchero, sull’acidità, sulla grandezza o sul peso degli acini senza considerare la qualità delle bucce dell’uva e quindi dei tannini dei vini. Un elemento cruciale per un vino rosso di cui nessuno all’epoca era consapevole in Borgogna. Fu un bel momento, in cui emersero tutto lo sciovinismo e l’incultura di un’intera generazione di professionisti locali. Allo stesso modo, sempre sotto la spinta di Guillaume, intervenni difendendo l’idea di selezionare nei singoli villaggi i migliori cloni e di creare, attraverso associazioni di viticoltori, delle viti-testimoni per conservare le piccole mutazioni locali delle varietà che contribuivano all’individualità dei caratteri delle denominazioni. Ci sono voluti più di vent’anni affinché queste idee si traducessero in una presa di coscienza generale riguardo a tutte queste tematiche.

Rinascita
Portata da alcuni viticoltori idealisti o più semplicemente consapevoli delle loro responsabilità nei confronti di un terroir così prestigioso, l’idea di un suolo vivo finì per affermarsi negli anni ’90.
Negli anni ’90, un piccolo gruppo di viticoltori progressisti ha creato l’associazione G.E.S.T. (gruppo di studio e monitoraggio dei terroir) per studiare finalmente i terreni borgognoni e il modo migliore per rispettarne l’originalità garantendone la durata. Nonostante le divertenti e stimolanti dispute scientifiche tra agronomi molto diversi come Claude Bourguignon e i suoi oppositori, questo ha fatto progredire l’idea di suolo vivo e dei diversi mezzi adattati alle risorse di ogni viticoltore per mantenere questa vita. Allo stesso modo, e in relazione alla sua difesa del patrimonio dei “climats”, Aubert de Villaine, che ha saputo cambiare completamente opinione, ha fondato con alcuni colleghi un istituto del pinot fin che contribuirà certamente a preservare una continuità di sapore e di espressione molto apprezzata.
Nel frattempo, la selezione clonale aveva comunque fatto dei progressi, offrendo al viticoltore una collezione di cloni più completa, non necessariamente i più produttivi o quelli dotati di un gusto più marcato e facilmente identificabile. Il lavoro di clonazione e di trattamento del materiale per renderlo sano era diventato meno aggressivo dal punto di vista termico e nel clone rispettava di più le qualità del ceppo di partenza. Tuttavia era impossibile garantire la piena salute delle vigne in un terreno contaminato dove persistono in profondità i portatori di un virus, impossibili da eliminare se non ricorrendo a un arsenale chimico pericoloso e peraltro vietato. Allo stesso tempo si iniziavano ad avvertire le prime problematiche riguardanti l’evoluzione generale del clima. Il concetto di viticoltura biologica e la sua dimensione più ristretta o più ampia, a seconda delle convinzioni di ciascuno, di viticoltura biodinamica, diventate il principale motore della trasformazione del vigneto.
Ho avuto la fortuna di conoscere uno dei più influenti ispiratori della biodinamica in viticoltura fin dagli anni ’80. François Bouchet, un viticoltore di Saumur che, con modestia e precisione, cercava di applicare i principi nati dagli scritti di Rudolf Steiner, ripresi da alcuni avanguardisti come Jean Claude Rateau (già nel 1979) o Didier Montchovet (nel 1984) da pionieri ancora più antichi, champenois o rhodaniens. La conversione più spettacolare alla biodinamica fu quella di Lalou Bize Leroy, commerciante perfezionista, diventata viticoltrice con l’acquisto nel 1988 della tenuta Charles Noëllat e con la co-amministrazione del domaine de la Romanée-Conti fino al 1991. Negli anni 1982 e 1983, mi aveva educato con il suo straordinario talento di degustatrice a tutte le sottigliezze dei grandi terroir borgognoni e le sue dégustations d’Auvenay rimarranno momenti magici nella memoria di tutti coloro che vi hanno partecipato. Amava le sue vigne e avendo approfondito la sua visione di viticoltura nella lingua originale (il tedesco) con gli scritti di Steiner, anche per quanto accadeva nella Loira con Nicolas Joly, Noël Pinguet (Domaine Huet) e tanti altri, convertì rapidamente le sue vigne prestigiose a una biodinamica molto personale, rigorosa nell’osservanza dei principi dell’antroposofo austriaco, ma molto originale nell’uso delle piante e nella conduzione, con risultati spettacolari dal punto di vista della qualità dei vini. La loro rarità e il loro prezzo li fecero rapidamente diventare leggende e ciò alimentò una rivalità invece molto positiva con altri viticoltori, prestigiosi o meno, a volte della sua stessa famiglia, come suo nipote Henry-Frédéric Roch.
Oggi non si contano più il numero e le superfici convertite a pratiche che preservano la natura e la vita del suolo o rafforzano immunità e resilienza naturale della vite. Con diversi gradi di interpretazione dei medesimi principi, rispetto delle fasi naturali della luna e persino delle stelle, arature più o meno profonde, inerbimenti, aumento della superficie fogliare, potatura e palizzamenti più conformi alla circolazione della linfa, reintroduzione della presenza animale, preservazione della fauna e della flora locali. Si spera che la violenza crescente del microclima – gelate crudeli a causa della precoce maturazione delle viti, essa stessa causata dal notevole riscaldamento climatico, grandinate ancora più crudeli a ripetizione, surriscaldamento delle uve in estati troppo calde e, purtroppo, blocchi di estati troppo secche – non riduca a zero questi grandi sforzi, sostenuti da prezzi di vendita capaci di renderli redditizi.

Correzione
In cantina, correzioni di debolezze dell’uva e errori di vinificazione sono stati per anni la regola. La presa di coscienza per un cambio di direzione necessario è stata lunga, a volte caotica e alla fine sempre attuale.
Le vinificazioni, a dir poco maldestre negli anni ’70 e ’80, seguivano la stessa curva perfezionista. Anni in cui l’enologia borgognona, nonostante la presenza dell’università di Digione, mostrava un orgoglio eccessivo per seguire il grande movimento che invece si stava costruendo a Bordeaux o Montpellier. Viveva nel ricordo delle sue origini, vale a dire la farmacia. I vecchi commerciali delle case di negoce parlavano persino con emozione e convinzione del lavoro dei loro “chimici”, il che mi faceva sorridere. Attenzione, la farmacia e gli studi per diventare farmacisti furono in grado di apportare grandi progressi alle vinificazioni, come in Champagne negli anni ’30, in settori specialistici come la selezione di lieviti performanti. Eppure in Borgogna dominava la routine, favorevole a un’enologia correttiva piuttosto che preventiva.
L’uva mancava di zucchero naturale? Si aggiungeva zucchero, e non a cucchiaini. Fino al 1988, ho visto pinot noir di Grand Cru vendemmiati illegalmente al di sotto di 11,5 gradi, persino al di sotto di 11, e rialzati a 13 gradi o più con zucchero di barbabietola o, per i più snob, di canna da zucchero. La legge autorizzava l’arricchimento ma offriva al viticoltore la scelta di correggere gli zuccheri vietando l’acidificazione, o viceversa di acidificare purché non si arricchisse con lo zucchero. Una grande maggioranza faceva esattamente l’opposto e sosteneva che l’aumento del volume di succo legato all’arricchimento con lo zucchero obbligava a sua volta ad acidificare per ripristinare l’equilibrio di partenza.
La repressione delle frodi effettuava di tanto in tanto verifiche e comminava multe ma molto spesso lasciava fare. L’uva mancava di tannino? Se ne aggiungeva in polvere e si considerava tra l’altro che ciò facilitasse l’igiene delle fermentazioni fissando meglio acidità e materie coloranti. La verità è che molte tinozze o cantine non offrivano un’igiene perfetta e gli incidenti nel corso della maturazione portavano a interventi fisici o chimici poco conformi al rispetto della materia prima originale. Le ricerche più avanzate provenivano tra l’altro dall’università di Reims e riguardavano più la microbiologia che l’enologia. Non si vedevano professori universitari consigliare le aziende vinicole come a Bordeaux, dove le facoltà erano molto presenti negli chateau.
Gli enologi erano mal pagati. Negli anni ’90 Jacques d’Angerville lottava affinché l’enologo della tenuta degli Hospices de Beaune avesse uno stipendio dignitoso. Anche i laboratori privati venivano pagati miseramente per le analisi, quindi si “rifacevano” vendendo prodotti enologici. Molti viticoltori ben radicati nel loro orgoglio borgognone consideravano che fosse degradante affidarsi ad altri e condividere con loro l’atto di vinificare, deridendo invece i colleghi che pagavano per consulenze enologiche. Spesso però non si rendevano nemmeno conto, durante la degustazione, dei seri difetti analitici. Deviazioni evidenti e dovute alla malignità di lieviti indesiderati, come la famosa Brettanomyces bruxellensis, erano assimilate a espressioni naturali e autentiche del terroir. Nei vini rossi l’unico elemento che veniva controllato era il suo pH, senza davvero interessarsi alla qualità della maturità finale dell’uva.
Nei bianchi, forme gravi di ossidazione precoce, percepibili fin dalla fine degli affinamenti, venivano recuperate in extremis con acidificazioni assassine oppure, viceversa, quando si esagerava, da deacidificazioni altrettanto drammatiche, prima che i consumatori e i critici internazionali si accorgessero del disastro. Centinaia di pagine sono state scritte per denunciare questo difetto o trovare soluzioni per evitarlo. A volte la colpa veniva data al tappo, a volte dall’eccessivo bâtonnage, allo squilibrio di azoto dei terreni che produceva squilibri nei mosti, e poi (forse più correttamente) alla mediocrità del materiale vegetale clonale.
Tutto ciò ha certamente avuto un ruolo per i migliaia di ettolitri che hanno invecchiato male tra il 1985 e il 2005. Solo recentemente si è compreso che gli imbottigliamenti in diversi domaine scarseggiavano di precisione. Da allora, ognuno si è impegnato per migliorare e finalmente oggi si può affermare che molti vini bianchi invecchieranno meglio. Ma a quale prezzo! Si vendemmia sempre prima per evitare eccessi di maturità, si cerca la massima riduzione nel sapore con l’approvazione di un pubblico e di critici che bevono e giudicano i vini sempre più presto e non hanno altro termine da usare se non “tensione” o “mineralità” al palato. Il riscaldamento climatico complica sempre più la scelta di una data ideale di vendemmia, eppure alcune forti personalità resistono alla moda e riescono a stupirci con probabilmente i più bei bianchi degli ultimi quarant’anni, assumendosi il massimo dei rischi.
Tuttavia i progressi più spettacolari sono avvenuti con i vini rossi. Un primo cambiamento è avvenuto intorno al 1985 con l’arrivo di nuovi enologi che, non essendo però borgognoni, alimentavano il nazionalismo di quelli locali. Due greci si successero nel laboratorio creato a Beaune dalla famiglia Meurgey: Athanase Fakorellis e poi Kyriakos Kynigopoulos, ammiratori della scuola bordolese, hanno iniziato ad offrire una maggiore precisione nell’analisi dei mosti e dei vini e a far notare difetti analitici, che passavano, come detto, per espressione del terroir. Con una particolare sensibilità per la pulizia aromatica dei vini bianchi e la maturazione più compiuta delle uve rosse, hanno formato nel loro laboratorio tutti i migliori consulenti enologici di oggi, come Dimitri Bazas, Sylvain Pataille, Pierre Milleman, con i quali ho condiviso tante degustazioni di vini giovani.
A Nuits-Saint-Georges, il libanese Guy Accad, con la sua doppia e notevole formazione a Montpellier come agronomo e come enologo – discepolo dei grandi Branas e Champagnol, troppo dimenticati al giorno d’oggi – faceva molto parlare di sé e della sua famosa “metodologia”. Avendolo conosciuto bene, posso sottolineare tanto le debolezze dell’uomo e dello scienziato quanto la fulgida intuizione di alcune delle sue idee. La sua specialità era innanzitutto l’analisi dei terreni e i consigli per la loro cura. Con la preoccupazione di produrre un’uva veramente matura e senza dover correggerne il carattere. Aveva ben capito i danni di sovrapproduzione e banalizzazione del sapore dei cloni certificati, proprio come le inaccettabili deviazioni aromatiche delle fermentazioni mal controllate. Da buon matematico, si concentrava soprattutto sulla cinetica delle fermentazioni, che conduceva dal freddo alla temperatura ideale con grande virtuosismo, nonostante avesse strumenti molto imperfetti. Certo, tendeva a proteggere eccessivamente l’uva inizialmente con la solforosa. Aveva compreso però che le dosi che raccomandava, intorno ai due litri di soluzione per tonnellata di uva, portavano a una buona selezione di lieviti naturali (non raccomandava mai quelli selezionati) e proteggevano dall’azione dei terribili brettanomyces. Inoltre non consigliava mai l’acidificazione dei mosti, come la maggior parte dei suoi colleghi.
Purtroppo, dopo il 1988, sul suo conto sono emerse esagerazioni, in particolare nel raffreddamento iniziale delle uve, al limite della congelazione, per meglio estrarre antociani e i loro precursori aromatici, al costo di una riduzione aromatica che veniva a mascherare la vera espressione del terroir. Ma le voci più stravaganti e false che circolavano erano quelle sulle manipolazioni. Lui stesso, per motivi legati alla sua vita privata, si lasciava andare a imprecisioni nei consigli che gli hanno fatto perdere gradualmente la clientela. Ma la sua influenza ha segnato tanti giovani viticoltori. Fra di loro, i più influenti sono stati forse i fratelli Jean-Pierre e Yves Confuron, il primo dei quali ha formato un’intera generazione di giovani o meno giovani professionisti presso il centro di formazione professionale di Beaune. Le pre-macerazioni fermentative a freddo hanno prevalso sulle stupide vinificazioni a caldo che caramellizzavano i vini per proteggerli dai danni della parziale muffa delle vendemmie. La moda della vinificazione a grappolo intero, che aveva prodotto i più grandi vini del secolo, con la tenuta della Romanée-Conti come vessillo, e che Accad preferiva nettamente alla vendemmia diraspata, a dispetto di viticoltori celebri come Henri Jayer, si è ampliata con la migliore maturità finale dell’uva. Certo, può succedere che l’eccesso di sole disturbi lo stile dei viticoltori più perfezionisti producendo gradi alcolici elevati e un carattere ben più meridionale della media dei vini della fine del secolo scorso. Ci si dimentica che vini dello stesso stile nel 1947 e, possiamo ormai dirlo, nel 2003 hanno ritrovato con l’invecchiamento il cammino verso un’eccellenza unica, dove unica sta per non conforme alla tradizione.
Un’altra tendenza privilegia i vini che vengono affettuosamente soprannominati “glou glou”. I vini cosiddetti naturali certamente fanno parte di essi. Ce ne sono certo di molti devianti, che hanno i loro estimatori e il loro pubblico, ma ovviamente ce ne sono anche molti gradevolissimi che, per gli entry level come aligoté o le denominazioni regionali, a un prezzo ancora piuttosto accessibile, sono perfetti per iniziare al piacere di bere. Non è così facile come si crede produrre un vino puro, morbido, equilibrato e affascinante, di cui il mercato ha tuttavia bisogno. Oggi fortunatamente sempre più viticoltori giovani e idealisti hanno successo. D’altro canto, a volte dovremmo essere più esigenti nei confronti dei vini provenienti da origini importanti, spesso frutto di vinificazioni eccessivamente ammorbidite, con materie seducenti ma anche con un’evidente mancanza di complessità. Un aiuto può darlo il recente miglioramento della viticoltura nonché il conseguente riscaldamento climatico (specie in zone un tempo fredde e dove la carenza stava proprio nella maturazione dell’uva), regalando ai grandi rossi tutta la loro ricercatezza, il loro fascino e la loro seduzione. Ma i volumi prodotti diminuiscono in modo preoccupante, portando ad aumenti talvolta spettacolari dei prezzi, e soprattutto a una rarefazione dell’offerta. In ogni caso, si assiste quindi a una riorganizzazione completa della proprietà vitivinicola e della commercializzazione, cosa che dovrebbe iniziare a preoccuparci.

Grandi e piccoli, viticoltori e commercio
Frutto di una lunga storia travagliata da crisi e guerre, il commercio dei vini di Borgogna non è, come si pensa, un fiume che scorre lungo e tranquillo…
La commercializzazione del vino di Borgogna influisce notevolmente sull’evoluzione dello stile dei vini, poiché, ad ogni generazione, il pubblico imprime i propri desideri e preferenze in materia di gusto. Preferenze che il commerciante, sia esso produttore o distributore, cerca di soddisfare, nella stessa logica della sua professione. Alla fine degli anni ’70, si viveva ancora nel ricordo del mezzo secolo precedente. Mi spiego: è un dato storico che il vigneto borgognone sia stato costituito e poi guidato da grandi proprietari, il principale dei quali era naturalmente la Chiesa. Con tutte le dispute tra diverse cappelle che hanno opposto abbazie gelose l’una dell’altra, e ordini monastici rivali, queste sono il sale della Storia.
La vendita dei beni della Chiesa non ha posto fine all’impatto dei ricchi e dei potenti. Il banchiere Ouvrard possedeva tutto il Clos Vougeot, la Romanée-Conti e molti altri Grand Cru. Le famiglie Latour, Bouchard e Chanson sviluppavano progressivamente sia i propri vigneti che la loro attività di commercio d’uva, mentre le famiglie Liger-Belair, Rebourseau, Pasquier-Desvignes, Marey-Monge, Duvault-Blochet e i loro eredi Chambon e tanti altri, partecipavano alla straordinaria crescita dei vini che ha segnato gli anni 1850 fino all’arrivo della fillossera. I contadini possedevano ovviamente vigne, poiché era necessario produrre vino in un’attività di policoltura per nutrire se stessi e la propria famiglia (ricordiamo che il vino era allora una bevanda alimentare consumata fino a diversi litri al giorno), ma molto raramente dei buoni terroir. La fillossera ha rovinato i ricchi e i potenti, che non si fidavano dei portinnesti americani, le violenze della storia (guerre e crisi economica del 1929) hanno fatto il resto. I terreni, anche nei grandi terroir, non valevano più granché e una piccola classe di contadini e piccola borghesia ha potuto così acquistare vigne, coltivarle e persino vinificare il proprio prodotto. Il che non li ha arricchiti affatto. Negli anni ’60, i viticoltori lavoravano duramente, le vendemmie erano molto irregolari in volume nonché in qualità e i commercianti, che smuovevano circa l’80% della produzione borgognona, spesso pagavano male l’uva.
Nonostante la rivoluzione delle AOC, spesso si preferiva il marchio alle denominazioni. A dire il vero, bisognava distinguere i negozianti sostenitori del marchio, spesso situati a Nuits-Saint-Georges, da quelli che fin dall’inizio avevano puntato sulle appellation, per la maggior parte situati a Beaune. Il marchio poteva significare la creazione di un gusto specifico, utilizzando vini di origine differente ricavati da taglio. Spesso il taglio era quasi servito a domicilio poiché negli anni ’70, per esempio a Morey-Saint-Denis, lungo la route dei cru, un noto négociant poteva offrire una scelta di vini miglioratori di colore o di sapore, la repressione delle frodi reagiva mollemente a queste attività. Ricordo ancora le parole certo sagge, ma troppo concilianti, pronunciate con un delizioso accento borgognone che arrotolava le r a piacimento da parte di Charles Quittanson, il potente direttore dell’ente statale di Nuits-Saint-Georges: “Non andremo certo a disturbare i bravi moltiplicando le ispezioni in cantina per impedire a qualche idiota di fare i loro miscugli!”.
Per i vini di entrata o per le appellation comunali si scelse la via più insidiosa ma forse più intelligente e cioè quella di preferire le cosiddette cuvée “rotonde” nate dall’assemblaggio di diverse esposizioni. In questo modo si decideva la tipicità di ogni villaggio, quindi un Beaune doveva assomigliare a se stesso, non a un Pommard o a un Volnay. Tutto ciò ha purtroppo dato vita a due effetti perversi: la creazione di stereotipi che non tenevano conto delle differenze tra le annate o del carattere originale del vitigno e le correzioni per unificarle, ma anche una gerarchia commerciale tra queste stesse denominazioni. Poiché era necessario fornire vini di tutte le fasce di prezzo, il commercio stabiliva dei prezzi minimi per ogni denominazione, con vini da comuni più prestigiosi come il Pommard, affiancati da quelli più accessibili come Auxey-Duresses o Monthelie. Allo stesso modo, non si pensava a vendere un Bourgogne, anche originario di vigne centenarie e di un sapore notevole, al prezzo di un vino ricavato da giovani vigne diluite di un villaggio celebre. Né tanto meno a pagare al produttore il reale valore della sua uva o dei suoi sforzi qualitativi. Ancora oggi, il mercato risente di queste gerarchie e il pubblico crede sempre che un Grand Cru sia migliore di un Premier cru, e che quest’ultimo sia migliore di un village, ecc, ecc.
Negli anni ’80 non c’era solo questo tipo di ambiguità. Nel 1973 ci si era appena liberati dalla pessima abitudine dei vini di ricaduta, in cui da una stessa vigna Grand Cru, si poteva produrre anche una piccola parte di Premier cru e una ancor più piccola di “village” o addirittura di Bourgogne generico. Immagino che molti non abbiano esitato a dire, come spesso veniva detto al giovane giornalista che ero: “Comprami questo bellissimo Borgogna. Sai, è uno Chambertin declassato!”. Ulteriore confusione si creò quando si aggiunse il nome dei migliori Grand Cru a quelli del proprio comune. Nel 1979, visitai con il mio mentore Michel Dovaz un famoso viticoltore di Vosne-Romanée che era stato a lungo sindaco del suo villaggio ma che, ribelle e nemico dell’idea repubblicana, declassava tutta la sua produzione. Si acquistava la bottiglia nuda, con etichetta da attaccare da soli e pagamento immediato in contanti, senza troppe differenze di prezzo, tre denominazioni: Richebourg, Clos-Vougeot e Vosne-Romanée. Sapendo che aveva anche vigne splendide in Échezeaux e Grands Échezeaux, gli chiesi perché non le offrisse in vendita. «Giovane, nessuno conosce il nome di questi cru, ma tutti credono che comprando un Vosne-Romanée, si acquisti un Romanée-Conti, quindi mescolo tutto e vendo di più» mi rispose.
Questo è cambiato molto da allora ed è affascinante comprendere perché. Prima di tutto, che lo si voglia o no, la creazione delle AOC e il loro controllo hanno aiutato molto a comunicare il fatto che i migliori vini locali provenivano da terroir specifici, ben delimitati e ben gerarchizzati, che a volte vengono chiamati “lieux-dits”, a volte “cru”. La parola “climat”, che nella sua accezione riunisce perfettamente i due precedenti, non era ancora di moda ma la convinzione dei buoni produttori e la natura del loro vino hanno progressivamente convinto il pubblico, soprattutto man mano che si rafforzava l’imbottigliamento presso le proprietà.

L’uomo e il suo modello
La Borgogna ha saputo costruire un ideale vinicolo che parla al mondo intero, senza però rinnegare le debolezze e i calcoli umani.
Per ragioni di spazio, di attrezzature e/o semplicemente di denaro, le proprietà hanno sempre venduto al commercio una parte importante della propria produzione. Con in testa però una volontà di “rivincita” contro il diktat degli acquirenti che, ovviamente, si rifiutavano di pagare il giusto prezzo per la merce giusta e approfittavano della loro potenza di acquisto. Tuttavia, la crisi del 1929 destabilizzò il commercio e quindi gli scambi. Il vino d’annata, come quello del 1928, era di notevole qualità ma non venne acquistato, se non a prezzi stracciati. Una generazione di produttori, va detto piuttosto benestanti ma coraggiosi, tra cui le famiglie Gouges, Rousseau, D’Angerville, Leflaive, decise allora di trattenere l’essenziale del proprio raccolto per produrre vino e venderlo direttamente. Questa situazione durò a lungo, poiché si dovrà attendere il 1959 per capire che vinsero la scommessa.
Nel frattempo, osservatori di primo piano come Raymond Baudoin, fondatore della Revue du vin de France, polemista influente sostenitore della creazione delle AOC, maestro di pensiero di giovani americani che diventeranno grandi importatori come Alexis Lichine o Franck Schoonmaker, hanno diffusamente trasmesso nei migliori ristoranti di Francia l’idea che il vino di proprietà era più autentico del vino di commercio. La sommellerie fu conquistata e i vini di commercio, anche i migliori, scomparvero dalla mappa dei grandi ristoranti. In continuità con le AOC, l’Accademia del vino di Francia fondata dal marchese di Lur-Saluces e dal barone Le Roy, con il sostegno dello stesso Raymond Baudoin, raggruppò le migliori aziende viticole del paese condividendo l’idea di un’autenticità superiore dei vini provenienti da domaine. Iniziarono a uscire libri che spiegavano la complessità dell’universo delle AOC e man mano che si internazionalizzava la diffusione dei grandi vini, gli esperti di ogni paese importatore trovarono nell’eccezione borgognona il modello storico ed etico di ogni grande vino autentico. A cominciare dai produttori di vigneti altrettanto storici come quelli del Piemonte o quelli delle valli tedesche della Mosella o del Reno, senza dimenticare i precursori di tutti, inclusi i borgognoni, nella classificazione storica del terroir, gli ungheresi di Tokay.
Ciò incoraggiò sempre più i borgognoni a difendere il proprio modello e a rivendicare il riconoscimento mondiale per i loro “climat”, che otterranno il 4 luglio 2015 con l’iscrizione a patrimonio dell’UNESCO. Questo riconoscimento implica l’accettazione di piccoli volumi di produzione, a causa della dimensione ridotta della maggior parte di questi climat e della loro divisione tra molti produttori diversi – il che rinforza ulteriormente la domanda, la rarefazione e il sentimento di esclusività che impongono, per i vini dei migliori o dei più noti di essi – e la speculazione sul loro prezzo. Poiché il migliore è a volte il nemico del buono, la “climatomania” può disinformare così come informare.
Spesso passa troppo sotto silenzio la lunga storia dei climats, della loro costituzione, dove certo la natura ha giocato il suo ruolo ma anche le dispute umane e la parte dei tribunali nella loro delimitazione. Per fare qualche esempio: i Gaudichots hanno ampliato il cru La Tâche; la Combe d’Orveau (in parte) quello di Musigny; il lieu-dit Dent de Chien il Montrachet. Poco a poco, lo spazio che inizialmente separava il Clos de la Roche e il Saint-Denis è diventato grand cru. Una parte di Aux Combottes si è unita al Latricières. Per quanto riguarda l’Échezeaux, possiamo immaginare l’abilità con cui furono assemblati i terroir vicini già nel 1936, ma con microclimi, altezza dei pendii ed esposizione inconsistenti. Ci si diverte con la delimitazione spesso irrazionale dei cru Corton e Corton-Charlemagne, ma anche nei climats che sembrano fusi in un pezzo ci sono differenze considerevoli, tra suoli bianchi o neri, parti argillose e parti più rocciose che si ritrovano nei vini se si conosce la posizione delle vigne. Il legame tra le terre bianche o rosse nel climat Bonnes Mares, tra Bonnes Mares nord e Bonnes Mares sud; tra la parte alta e bassa del climat Les Rugiens; tra il Clos des Chênes lato Taillepieds e la sua parte alta; e tra l’espressione nel cuore di Puligny e la sua parte sud di Chassagne del Montrachet? Potremmo rendere gli appassionati ancora più confusi parlando dell’età delle vigne, della scelta del materiale vegetale, del portainnesto, della resa, delle date di vendemmia differenti, del trattamento dell’uva diverso, della pressatura dei bianchi, di estrazione e temperatura di fermentazione per i rossi, dell’origine e del sapore delle barrique per entrambi, e tanto altro. Tutto questo contribuisce, tanto quanto il luogo, alla costruzione del gusto specifico di ogni cuvée ma anche alla sorpresa e al fascino rinnovato di ogni degustazione, che alimentano la conversazione e i dibattiti tra sensibilità differenti e fanno tutto l’interesse umano e culturale della questione.

Fortunatamente le vecchie diatribe e i rancori non hanno più motivo di esistere e l’evoluzione del commercio tende a riavvicinare négoce e proprietà. Da un lato, si ricompongono, a causa dei prezzi delle vigne, le grandi proprietà appartenenti ai ricchi francesi, come nel XIX secolo. I vari Arnault, Pinault, Bouygues acquistano splendide tenute e consentono loro di lavorare nelle migliori condizioni, così come le assicurazioni e le banche che, peraltro, non si limitano alla Borgogna. Poi, in modo ancora più determinante, molti viticoltori vedono ad ogni successione diminuire le quote dei domaine familiari, così come il volume di vino commerciabile.
Viste le produzioni sempre più ridotte, poiché la domanda non è mai stata così forte, nazionale e internazionale, numerosi viticoltori compensano la mancanza di vino adottando lo status di négociant, il che gli consente di acquistare uva dai familiari, da vicini di vigna o dai propri colleghi e di comprendere cosa accade dall’altro lato della barricata. Insomma, per pragmatismo, si avvicinano al concetto internazionale di winery, dove il produttore può anche assemblare le proprie uve con quelle che compra. Con un know-how riconosciuto dagli acquirenti che fanno sempre meno fatica a distinguere tra le cuvée provenienti esclusivamente dalla proprietà e quelle da negoce. La legge, invece, continua a esigere chiarezza sulla provenienza e che in un caso si indichi sull’etichetta “messo in bottiglia in cantina o nella proprietà” e nell’altro “messo in bottiglia da tizio”, senza far apparire la nozione di proprietà. I furbi compensano quest’obbligo con trucchi di marketing che fanno sembrare stranamente simili la tipografia e lo stile delle etichette, ma è un gioco sleale! D’altro canto, e ciò è più preoccupante, la dispersione dell’offerta riduce ulteriormente i singoli volumi prodotti e non contribuisce alla stabilità dei prezzi.
Ma ci sono fattori molto più importanti della natura e della forma dell’attuale commercio, anche più ansiogeni. Tutte le intelligenze agronomiche ed enologiche di oggi stanno cercando di trovare le risposte più adatte ai notevoli cambiamenti climatici che stiamo vivendo e che minacciano non solo il carattere tradizionale e unanimemente apprezzato dei vini, ma la loro stessa esistenza. Nessuno mette più in dubbio l’avvento del riscaldamento globale. Negli ultimi quarant’anni, il clima ha conosciuto un aumento medio di quasi due gradi, il che lo avvicina a quello che esisteva mille chilometri o quasi più a sud. Questo riscaldamento ha modificato soprattutto la costituzione delle uve rosse. In passato, i pinot neri al di sopra dei 12 gradi naturali non si vendemmiavano praticamente più. Oggi superano ampiamente 14 gradi in anno solare, con viceversa un’acidità sempre più bassa.
I classici zuccheraggi di un tempo lasciano ormai posto alla speranza di legalizzare il “mouillage”, ovvero l’aggiunta di acqua al mosto per ripristinare un equilibrio nella bevibilità richiesta, e lo comprendiamo, dal pubblico come dalle autorità. Fortunatamente, si stanno studiando altre piste. Alcuni vorrebbero che si accettasse di introdurre varietà più adatte al riscaldamento, altri, che ci sembrano più credibili, preferiscono che ci si concentri maggiormente sull’aiuto da fornire alle varietà storiche per adattarsi a queste nuove condizioni.
Per il pinot nero, solo il cambiamento della potatura sembra possibile per proteggere maggiormente l’uva delle scottature. Si vedono chiaramente gli effetti benefici dei primi esperimenti in questo campo. Si può anche giocare sulla densità di impianto se mai l’acqua dovesse mancare, o sulla direzione delle piantagioni, tornando, quando la pendenza lo consente, a impianti paralleli alle curve di livello. Per i vini bianchi, si potrebbe maggiormente giocare sull’adozione di portinnesti più tardivi che ritarderebbero un po’ la maturazione dell’uva preservandola dalle gelate precoci. O, ancor meglio, riabilitare i fratelli dello chardonnay, i troppo dimenticati aligoté, melon, sacy, tutt’altro che mediocri come si crede e tutti i cugini genetici dei vigneti vicini del Jura o della Champagne, a cominciare dal savagnin, per il loro contributo di acidità e a volte il loro grado alcolico più basso.
In ogni caso, ci si rende oggi conto dell’importanza ancora maggiore da attribuire alla vita dei suoli e alla loro cura, che favorisce ovviamente la resilienza già naturalmente notevole delle varietà della famiglia Vitis vinifera. La gestione dell’acqua dovrà anche condurre a preservare meglio le piogge invernali per meglio gestire lo stress idrico di estati troppo secche. Resta l’arduo problema della violenza di alcuni fenomeni meteorologici. La vite ben palizzata non teme molto il vento ma il gelo, la grandine e lo sviluppo delle malattie, che provengano da virus o crittogami. Per il gelo, non c’è nulla da fare contro le gelate tardive, se non adottare sistemi di protezione infinitamente costosi e complessi. Ma si possono rendere meno dannose le gelate precoci a ripetizione che conosciamo ritardando l’anticipo delle viti che si erano tanto ricercati quando non c’era bel tempo e caldo a sufficienza. La grandine si combatte anche più facilmente, ma sarebbe necessario legalizzare la posa di reti, o generalizzare la lotta globale dei cannoni anti-grandine. Con le malattie la questione è più difficile. Non siamo riusciti a sconfiggere la fillossera, ma si è adattata la vite alle sue nocività mediante l’innesto. Si è anche fallito nello sconfiggere i nematodi che trasmettono i virus, ma in verità il principale di essi, il court-noué, favorisce a volte la qualità diminuendo la quantità.

La migliore soluzione sarebbe una maggese (terreno agrario tenuto a riposo, o anche opportunamente lavorato, affinché riacquisti la sua fertilità, ndt) di dieci anni al massimo, forse è la più difficile da applicare sul piano economico ma in ogni caso la stupida legge attuale la vieta, esigendo che si ripiantino troppo in fretta terreni infetti. Le altre malattie preoccupano di più, ma si riesce a limitare sempre più i loro effetti attraverso l’uso intelligente delle piante protettrici, la rapidità dei trattamenti e la loro efficacia. Un viticoltore non vivrà mai tranquillo o completamente felice, come molti agricoltori d’altronde, ma un’intelligenza in costante allerta, basata sull’osservazione quotidiana della vite e una risposta adattata a ogni difficoltà rimane l’onore della professione. Ai vecchi osservatori come il sottoscritto, sembra che i viticoltori borgognoni della nuova generazione siano ben più attrezzati di quelli delle generazioni precedenti ad affrontare queste sfide.
Michel Bettane
[Le foto in copertina e quelle presenti nel testo sono state scattate durante l’ultimo viaggio in Borgogna nel marzo 2024. Credits: Simone Di Vito]

![[Longform] La monografia esplosiva ed esclusiva di Michel Bettane sulla Borgogna (tradotta in italiano)](https://www.intravino.com/wp-content/uploads/PXL_20240318_175027762-e1724667381339-750x399.jpg)



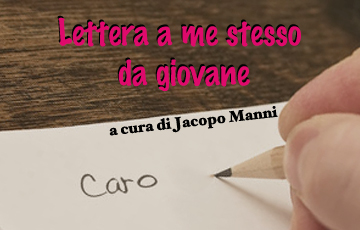






4 Commenti
Lanegano
circa 2 mesi fa - LinkInteressantissimo.
RispondiAnna Valentino
circa 2 mesi fa - LinkMolto interessante! Ho organizzato la mia vacanza esattamente in questa regione 🍀
RispondiRuggero Romani
circa 2 mesi fa - LinkIn uno sceneggiato francese avevo sentito che la redditività di una vigna in borgogna è l'1% del valore della vigna. Bettane in questa intervista lo confeconferma .Vi sembra normale?
Rispondierique
circa 2 mesi fa - Linka rileggere i resoconti degli anni ottanta del secolo scorso, mi viene in mente la battuta che, al tempo, un famoso produttore irpino fece a mio nonno: “nel vino ci va anche l’uva”.
Rispondi